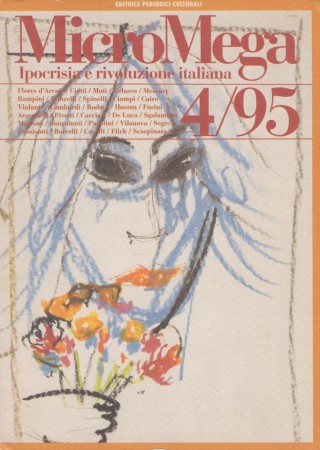
Pasolini ha nostalgia della «civiltà». Della Kultur con la sua superstizione dell’origine, del fuocherello di ciocchi di faggio, della vita contadina saggia e fedele, delle brache con le toppe e delle panche accanto al fuoco. Di tutto ciò insomma che Heidegger magnificò nel suo scritto essoterico Perché restiamo in provincia? e sui cui ci fece ridere Adorno. Dobbiamo tuttavia chiederci quanto ancora è necessario sostenere e trattenerci in questa civiltà. Per quanto ancora dobbiamo credervi e sopportarla. Essa è legata al culto dell’origine, a quello della nascita, e legata ancora al sorgere del mondo, al sentimento di qualcosa che ci generò con affetto. La civiltà verso cui andiamo, e che per noi ha già sostituito questa, è invece guidata dall’idea del tramonto del sistema solare, dai grandi fatti cosmici, dalla morte delle stelle, dalla temperatura zero, dall’idea del collasso finale. Qualcosa infatti ha mutato le condizioni mediante cui tutto ciò, almeno formalmente, restava lontano da noi, né poteva interessarci – sembrava a tutti – per la enorme distanza temporale, mentre era ovvio che ci interessassero Cesare e Napoleone. Qualcosa è avvenuto che ha fatto sì tuttavia che ciò divenisse solida conoscenza annullandone la remota distanza temporale e tramutandolo in esperienza possibile nel più puro senso kantiano: l’avvento del sentimento di contemporaneità agli stati finali del nostro sistema solare. A partire da esso, all’ex parola d’ordine: storicizzazione del mondo, si è sostituita la cosmicizzazione in atto della storta.
«Chi conosce la catena delle conseguenze, misura la grandezza della responsabilità», come si legge nella Ethik di Nicolai Hartmani, opera dura e insopprimibile. Ma ogni previsione allarma i responsabili della morale che si tutelano. Il mandato dato da coloro che agiscono, scambiano, perseguono un profitto, ossia da coloro per cui c’è necessità di un’etica, è esplicito. La responsabilità, intesa veramente, frenerebbe ogni azione: in breve tutti risulterebbero ladri e assassini. Man mano dunque che si afferma il dominio di quelli che intendono agire senza impacci di sorta, se non il minimo indispensabile, la morale che li rappresenta si libera di ogni punto di appoggio che non può aversi, come fu detto per loro conto, «né in cielo né in terra» ma solo nell’intenzione «quali che ne siano le conseguenze». Gli esecutori del mandato, come gli attuali direttori di coscienza, troncano dunque di netto le azioni dalle conseguenze. Bentham, che le calcola, è uno spudorato. La responsabilità integrale è roba da regno dei cieli, mentre quello minima, quella legale, è assicurata.
Come direttore di coscienza Pasolini è un Escobar sputato: del «consumismo» inette in luce il piacere non la tragedia. Egli si ferma all’effetto joujou. A Modame Panckoucke. (Il suo marxismo è in realtà una specie di Blut-and-Boden Ideologie. Legato al Kreislauf des Lebens, all’eterno ritorno della riproduzione. Da qui il suo equivoco sul «consumo»). Non si rende conto anzitutto che esso è consumazione. Che brucia, tramite il mazzetto di fieno delle merci, le fonti stesse dell’esistenza.
Ma andiamo per ordine. Milioni di oggetti incatenano i nostri desideri che prima erano, si dice, il desiderio di una donna, di un asilo per la notte, di un’alba, del cibo e di poco alti». Oggi si consuma senza desiderare. Lutero reagì a un consumismo simile. Oggetto ne furono carismi, sacramenti, Dio stesso… Il Thesaurus meritorum costituiva una ricchezza oggettiva tanto quanto The Wealth of Nations. Le questioni che poi sorsero attorno alla ricchezza materiale, o ricchezza sans phrase, riproducono quasi alla lettera quelle sorte attorno alla ricchezza spirituale. Si scatena una vera e propria «questione sociale». In teoria tutti sono «spiritualmente» ricchi, praticamente c’è invece ima disparità messa in evidenza dalla lotta attorno all’eucarestia: ottenere per tutti la comunione sotto le due specie, del pane e del vino. Nel corso di questo scontro, l’interiorizzazione protestante distruggerà la ricchezza dei carismi che per essere «ricchezza» deve essere esteriore, sensibile.
L’intera ricchezza carismatica viene dissolta nello stesso momento in cui ciò che la manifesta viene rifiutato come superstizioso e demoniaco. La distruzione del concetto stesso di ricchezza spirituale visibile ed esterna, non messa a ferro e a fuoco dal consumo ma risucchiata in una problematica interiorità, sta a monte della ricchezza poi divenuta materiale, della ricchezza sans phrase, che la sostituirà, dando luogo su per giù agli stessi problemi. Mentre il potenziamento dell’interiorità potenzia il desiderio di Dio proprio perché le «cose» non lo rendono più visibile. Nel Vulgarkatholizismus invece (nel consumismo religioso) il cristianesimo viene consumato sino all’osso.
D’altra parte l’industrialismo ha «realizzato» il platonismo. Il mondo delle Idee è stato preso in carico dall’industria che riproduce le Idee come «cose» in milioni di esemplari. Ciò che un giorno fu Idea, in un mondo celeste ma esangue, troneggia oggi nei lussuosi negozi, nei grandi mercati a cui si rivolge estasiato il platonico odierno, l’uomo consumatore. Ma ciò che egli consuma va al di là delle sue stesse intenzioni. Egli consuma la civiltà di cui sotto sotto ne ha basta. Si afferma dunque un ethos del consumo e un’etica conseguente. All’interno del pessimismo mondiale il consumismo non è che una forma di quell’«annullamento» che predicavano i padri. Quando il pessimismo si scontra con l’ottimismo progressista, il risultato «antiprogressista» è scontato. Ma lo è nei limiti in cui il pessimismo parla di ciò di cui il pensiero progressista tace. Tutto ciò sembra antiprogressista ma lo è solo nei confronti della visione volgar-filistea del progressismo, quella dei battaglioni di canaglie che marciano sulla meta al rullo dei tamburi.
La storia? La storia è fatta dai coglioni. Il consumismo dissolverà dunque la più bella civiltà che la storia abbia mai avuto. Questa non è una sciocca profezia, ma una attendibile previsione. Il concetto di «tramonto» o quello complementare di «compimento», immensi quando fu nella visione della storia, non vengono più trattati con sufficienza e il ricordo della «fine del mondo antico» si fa oggi angosciante. Pensare che la civiltà dell’Occidente possa riversarsi al di fuori e continuare con altri nomi è sconoscere o trascurare che le «forme» o vivono, o decadono e periscono. Non è possibile altro. Quegli storici, ma anche menti acute di teorici, che si affannano a vedere il mondo antico riversarsi in quello che vi succedette, dimenticano che diecimila libri ottimamente documentati nulla possono contro ciò che si visse come tale. Macbeth può essere pure stato un uomo virtuoso ma lo storico che lo dimostrasse farebbe sorridere di compatimento il lettore di Shakespeare.
Si badi, quella dell’Occidente non è una civiltà di fronte a un’altra civiltà che si chiamerebbe, poniamo, «Oriente». Quelli i quali pesano entrambe dosandone i mali e i beni, chiunque essi siano, non hanno capito, verrebbe voglia di dire, che «civiltà» è solo una, l’«Occidente». Quello dell’Oriente è solo un modo di vivere. Mentre «civiltà» è l’energia di una forma che si impone direttamente sul «mondo». Se «Occidente» è una «forma», esso non «dilaga», ma annette e ingloba tutto ciò che ne fa parte ed espelle il resto come rifiuto. L’Occidente si impone. Se solo l’Occidente è civiltà e tutti gli altri (l’Oriente, ad esempio) non sono che modi di vita, il tramonto dell’Occidente equivale al tramonto della civiltà come tale. Resteranno modi di vita come quelli degli insetti o degli uccelli. Alla stessa maniera che non possiamo parlare di civiltà delle mosche o dei cavalli ma soltanto cli come vivono le mosche o i cavalli, potremo parlare di come vivono questi o quegli uomini, ma non più di «civiltà». Senza la protezione della «civiltà», in preda all’emozione possente della contemporaneità alla fine del mondo, bande di occidentali praticheranno la loro etica – valere, non «essere» – e la condanna del mondo mentre le stelle si spegneranno una a una…
Chi oggi si presentasse con la fermezza di un filosofo della storia – deprecato al presente come profeta di sventura o imbecille senza pari – non potrebbe vedere nel «consumo» che l’occasione tramite la quale si consumano le fonti stesse della civiltà. Il ciarpame consumato è la stessa civiltà nel momento preciso in cui essa è diventata ciarpame.
Manlio Sgalambro, Ethos del consumo in “MicroMega”, n. 4/95, ottobre-novembre 1995, pp. 204-207